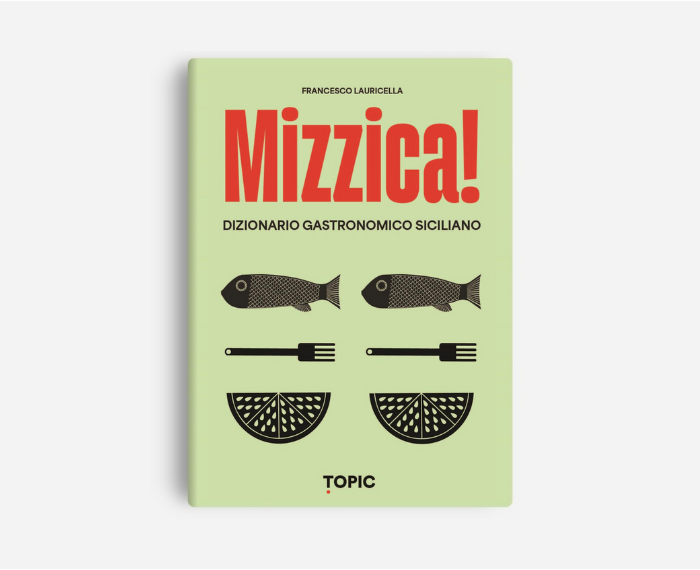La cucina è un linguaggio universale che unisce e abbatte le barriere, è vero. Al contempo, definisce l’identità di una cultura e presenta un’infinità di meravigliose sfaccettature. Tutto parte dal linguaggio, che segna confini senza però apportare restrizioni.
C’è un tacito accordo per cui tutti siamo liberi di chiamare il cibo a nostro piacimento. A volte nascono grandi simpatiche dispute, si sa (vedi Arancin*, di cui parleremo dopo), ma siamo tutti concordi, soprattutto noi siciliani, su quanto sia importante tramandare termini e ricette che ci stanno a cuore.
Si tratta di veri e propri tesori culturali, da ricordare, tracciare e custodire. D’altronde, la cucina siciliana racchiude una storia millenaria, una commistione di individui di origini, religioni e culture diverse con il risultato di costruire un’identità originalissima che ha dato vita a una tradizione gastronomica senza confronti.
Custodire. È proprio il fine, insieme alla curiosità, che ha spinto Francesco Lauricella a redigere Mizzica, il dizionario gastronomico siciliano.
Molto più di una mera elencazione di parole e definizioni; è un’immersione nelle radici profonde della cucina siciliana. Dando spazio a ricette tramandate di generazione in generazione, ma ormai cadute in disuso, e alle peculiarità dei prodotti locali, mira a catturare la complessità e la ricchezza della cucina dell’isola.
Francesco ci ha raccontato il suo bellissimo percorso di ricerca. Ecco la sua intervista!

Foto di Shameel Mukkath
Come nasce l’idea di Mizzica, Dizionario Gastronomico Siciliano?
Una ventina di anni fa, forse di più, una giornalista americana mi chiese di tradurre in siciliano un articolo che aveva scritto su uno chef siciliano. Per tradurre questo testo, abbastanza lungo, ho creato un mio piccolo dizionario siciliano. Poi l’ho abbandonato tra i file del mio computer.
In seguito, per motivi di lavoro, ho mangiato molto in giro per la Sicilia e, quando mi capitava di assaggiare qualcosa dal nome strano, lo segnavo nei miei taccuini.
Durante la pandemia, mentre riorganizzavo gli hard disk, ho ritrovato il dizionario e ho pensato di portare avanti il lavoro. Oltre ad aggiungere nomi di piatti, mi sono fatto prendere la mano e ho aggiunto i nomi dei pesci, abbinando la specie al termine in dialetto. Poi, a seguito di tante ricerche, ho trovato nomi di piante di tutta la Sicilia. Ho studiato su testi specifici per ogni parte della regione: su quelli dedicati all’Etna, quelli dedicati alle Eolie e così via.
Un altro momento importante, che mi ha spinto alla creazione di questo libro è poi stata una cena con degli chef. Mentre mangiavamo degli asparagi, mi sono accorto che nessuno di loro li chiamava alla stessa maniera.
Perché hai scelto di intitolarlo “Mizzica”?
Per me è una delle parole che più rappresentano la sicilianità, ormai entrata nel dizionario italiano per la sua potenza, oltrepassando i confini della regione.
Mizzica è l’esclamazione che ogni cuoco vorrebbe sentire quando porta qualcosa in tavola.
Prevale sul dizionario una variante specifica del siciliano?
Io sono di Licata, in provincia di Agrigento. Ho vissuto poi tanto tempo a Palermo, ma non posso dire sul dizionario vengono registrate solo le varianti utilizzate in queste due città, anzi. Avendo fatto tanta ricerca, non ho escluso nulla.
Se doveste riscontrare effettivamente una variante prevalente per numero di termini analizzati, non era comunque mia intenzione!
Da dove derivano le tue ricerche?
Innanzi tutto dalla mia esperienza personale. Ho poi consultato tantissimi testi siciliani dell’800 e del ‘900, poi libri di cucina antichi.
Persino libri di cucina del ‘500 e del ‘600 non siciliani, ma che magari fanno riferimento alle nostre ricette. Ovviamente tanti libri attuali di ricette siciliane, manuali verticali su piante e animali per individuare le diverse specie.
Oltre al vero e proprio dizionario in ordine alfabetico, troviamo anche altri contenuti?
All’interno sono contenute una dozzina di schede su argomenti precisi come, ad esempio, l’arancino, la caponata e i classici della cucina siciliana, pensate soprattutto per i lettori non autoctoni.
Troviamo anche qui la famosa diatriba Arancino/Arancina?
Sul dizionario troverai Arancin* con l’asterisco, ma non per sottolineare la differenza linguistica tra le due parti della Sicilia, semmai per sottolineare il fatto che, a prescindere da come lo si chiami, rimane un piatto unico nel suo genere!
Trovi anche delle curiosità in merito. Ad esempio, nel romanzo “I Viceré” di Federico De Roberto, testo simbolo di Catania, questa pietanza viene nominato al femminile, mentre tra le ricette palermitane dell’800 troviamo il termine declinato al maschile.
Credo che il motivo per cui i Palermitani declinano il termine al femminile derivi da una guida Touring degli anni ‘30. Non si sa ovviamente il motivo per cui abbiano usato il femminile.
Poi Montalbano lo ha usato al maschile, il Ministero delle politiche agricole lo usa al maschile.
Quindi rimane ancora irrisolto il quesito e non esiste ancora alcuna spiegazione storica.
Una cosa che ho notato è che, a discapito di ciò che si pensi, l’arancino è una ricetta abbastanza recente. Dal 1.100 in poi non se ne parla. Negli antichi dizionari siciliani è una pietanza dolce, una crocchetta di riso dolce.
Oltre ad Arancin*, quale altra parola merita un approfondimento?
Su ogni termine, troverai una storia, una favola, che vale la pena leggere, ma una delle parole che amo di più è cucunci, i frutti del cappero, che molti neanche conoscono.

Cucunci
Poi cabbasisi, che non prende qui l’accezione utilizzata da Camilleri, ma il suo significato autentico, una tipologia di tubero.
In che modo Mizzica può essere un libro da visitare?
Anziché parlarti di una città nominata sul dizionario, ti dico un luogo: il mercato. La Pescheria di Catania, la Vucciria a Palermo, oppure il mercato di Ortigia, o qualsiasi altro mercato, sono luoghi davvero affascinanti e magici, in cui si incontrano ingredienti da diverse parti del mondo. Così come in Sicilia sono arrivati da lontano il fico d’india, il pomodoro, le arance, oggi nei mercati troviamo tanti ingredienti strani, che per destino si uniscono e creano delle ricette bellissime.
Mi piace sempre passeggiare per i mercati quando ne ho l’occasione, non solo per i colori e profumi, ma anche per incontrare personaggi folcloristici.

La Pescheria di Catania Foto di Yoav Aziz su Unsplash
Quali libri siciliani secondo te non possono mancare nella libreria di un lettore?
Sicuramente Il Gattopardo e I Viceré. In entrambi si lascia ampio spazio al cibo e spiegano meglio di qualunque altro trattato sociologico la “sicilianità”. Illustrano i vizi, le virtù e l’approccio culturale che ci caratterizza nell’affrontare la vita.
Poi, essendo agrigentino, non posso non nominare Leonardo Sciascia. Credo che sia, insieme a Gesualdo Bufalino, il più elegante scrittore siciliano. Sciascia più di tutti non ha mai avuto paura di parlare della violenza nella cultura siciliana. La sua crudezza è illuminante.
“Mizzica” nasce con l’ambizione di portare nel terzo millennio termini siciliani del XIX e del XX secolo, ormai usati raramente e che rischiano di essere dimenticati.
Chi è appassionato di cucina troverà tutti i termini necessari per mangiare, bere e cucinare in siciliano. Ogni pagina è un invito a esplorare l’ampio e variegato continente gastronomico siciliano, dove ogni parola è intrisa di storia, cultura e passione.
Mizzica è distribuito da Giunti ed è acquistabile in tutta Italia.